
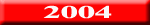
- Elisa
Montessori
- “Frammenti
dall’Orto Botanico”
- 10
dicembre 2004 – 4 gennaio 2005
-
- acquarelli
2004
- a
cura di Stefano Malatesta.
-
- In
esposizione 35 acquarelli
appartenenti alla più recente produzione della pittrice
genovese che vive ed opera a Roma.
- Nella
lunga, ricca ed articolata produzione della Montessori, sia in
ambito stilistico, sia in quello specifico della tecnica (dalle
carte alle tele, dai mosaici ai preziosi libricini a tema, alle
ceramiche), tutto testimonia la vivacità e l’eclettismo
dell’autrice.
- Orizzonti,
montagne, colline, piante, paesaggi abitati da figure, ma anche
da forme astratte, sono i temi ricorrenti delle sue opere che
“...se si potessero attraversare, come in Alice nel paese
delle meraviglie... ci troveremmo immersi in al di là dello
specchio, in un mondo, che assomiglia a quello conosciuto, ma
che, di fatto, non lo è, tanto è differente per bizzarria,
stravaganza e fantasia.” (Barbara Tosi,
La memoria del paesaggio e il paesaggio della memoria,
2001).
- Dal
1951, anno della prima personale, ad oggi, numerose sono state
le mostre collettive e personali della pittrice sia in Italia
che all’estero.
- Si
ricordano inoltre le partecipazioni alla Biennale di Venezia del
1982, alla Biennale d’Arte di San Paolo del Brasile del 1983,
alla Quadriennale di Roma del 1986, alla mostra d’arte
contemporanea a Palazzo della Farnesina di Roma nel 2001.
- Hanno
scritto sul suo lavoro tra gli altri: Enzo Bilardello, Arnaldo
Romani Brizzi, Laura Cherubini, Martina Corgnati, Mario de
Candia, Nadia Fusini, Stefano Malatesta, Filiberto Menna, Dario
Micacchi, Achille Bonito Oliva, Elisabetta Rasy, Anne Marie
Sauzeau Boetti, Barbara Tosi, Paola Watts.
-
- Ai
visitatori della mostra sarà omaggiato il “CalendArte
2005”, calendario illustrato con le opere di Elisa
Montessori e con testo di Stefano Malatesta e poesie di
Valentino Zeichen.
-
-
- Testo
di Malatesta:
- LA
DESCUBRIDORA
-
- Quante
signore abbiamo conosciuto, simpatiche e intelligenti, che
dicevano di essere pittrici. E in realtà erano e intendevano
essere restauratrici, disegnatrici di interni e di trompe l’oeil
che lavoravano in vecchi palazzi per metà della loro giornata:
un lavoro di pazienza e di meticolosità, a volte prezioso,
aiutato da un inconfondibile buon gusto, rilasciato a piene mani
quando si trattava di arredare la propria casa. E sempre con
mobili orientali, pigiami orientali e cucina orientale. E quando
erano costrette a pronunciarsi sullo stato di salute dell’arte
contemporanea, che non seguivano bene e di cui avevano una
conoscenza piuttosto indiretta, dicevano cose che sembravano
sentite, ma vaghe, mai controcorrente, di genere ecumenico, per
accontentare tutti. E avrebbero fatto qualsiasi cosa, pur avendo
un temperamento non particolarmente esibizionista, per essere
fotografate nei loro studi su una di quelle riviste di moda,
dove facevano vedere le case più belle di “Lui” e di
“Lei”.
Elisa Montessori è esattamente il contrario. Spero non vi
farete un’idea sbagliata, andando nel suo bellissimo studio di
via della Lungara, davanti ad una tazza di ottimo te, servito
con tutto ciò che occorre. Quello è il momento in cui Elisa
mette in mostra tutte le sue doti mondane e qualcuno crede
ingenuamente che il suo talento sia circoscritto a quello che
vede e che sente. E non si accorge che Elisa sta pensando ad
altro, a come risolvere un passaggio, a come rendere ancora più
trasparente il rosso e il giallo senza che l'acqua tracimi dai
limiti fissati. E’ sempre da qualche altra parte, non perché
si annoi quando qualcuno la va a trovare, o si rifiuti ad una
conversazione di gruppo il cui tema principale è l'insulsaggine
dei concetti appena dibattuti. Piuttosto perché l’artista
sperimentale, e lei è una vera “descubridora”,
quando avanza nella terra di nessuno non ha molto tempo da
dedicare agli altri. Può dedicare l’affetto, quello si, ma
non il cervello e le mani, la vera sede dell’intelligenza
secondo i greci. E per essere sicuri di ritrovarla quando è
sparita, la si può cercare in qualche zona di confine,
borderline, mentre insegue soluzioni impossibili, in quello
stretto spazio che esiste ancora tra il colpo di genio e la
cazzata. E non è detto che si ritrovi sempre dalla parte
giusta. E sto parlando, naturalmente, anche di piccole audacie,
di dilemmi e scelte d’arte che non sono tra Roma e morte, ma
piuttosto tra Roma e Orte, come diceva Longanesi. Ma qualsiasi
tentativo, anche il più modesto, di uscire dal vagone piombato
delle idee ricevute e di fare in modo che l’ingombrante treno
delle cose viste venga deragliato e vada in malora, è sempre
infinitamente meglio del copia copia generale che caratterizza
una buona parte dell’arte contemporanea. E’ vero che questa
graziosa attitudine al furto è riscontrabile in ogni epoca, ma
oggi è molto più evidente perché il giorno dopo di una
esibizione, cominciano ad arrivare i fax con le proposte
sfacciatamente identiche.
Quindi state attenti a quell’aria svagata che spesso assume:
è la conseguenza di questo stare altrove e maschera una
determinazione e una convinzione in tutto quello che
intraprende, così da renderla soavemente temibile. Una volta
l’ho paragonata a Miss Marple, celeberrimo personaggio di
Agata Christie, che sempre viene sottovalutata dall’assassino
spietato, il quale poi però non riesce mai a cavarsela, quando
c’è la gentile signora nei dintorni. E qualche giorno fa, nel
suo studio, passando in rassegna gli acquarelli che doveva
spedire a Palermo, mi è venuto spontaneo di dirle che aveva
scelto una tecnica pittorica in qualche modo simile a lei. Perché
tutt’e due, la tecnica e l’interprete, si presentavano alla
gente, come diceva Tina Pica, con una messa in scena così
ingannevole, che vale la pena di parlarne.
In Italia l'acquarello non ha mai avuto un maestro delle
proporzioni di Turner in Inghilterra o di Klee in Svizzera e in
Germania. Un po’ appesantiti dal peso di una meravigliosa, ma
ingombrante tradizione, qui gli artisti hanno sempre preferito
l’olio, dopo i magnifici secoli dell’affresco. A molti la
leggerezza dei colori che contengono l’acqua, la loro superba
trasparenza è sempre sembrato un difetto, in particolare per le
opere grandi, ma anche per quelle di minore formato. Ed uno di
quei luoghi comuni, di cui ti parlano prima, riguarda la
presunta facilità di lavorare con l'acquarello: basta vedere
che colori innalzano sul cavalletto i principianti nelle
domeniche passate su una roccia di fronte al mare. Una volta ho
parlato a lungo sull’uso dell’acquarello ad uno dei maggiori
tecnici sul campo o sulla battaglia, un signore che ha abitato a
lungo presso la mia casa di Trastevere e che poteva essere
scambiato per una copia conforme del capitano Haddock,
l'inseparabile compagno di Tintin nei fumetti di Hergè. Nella
realtà il capitan Haddock - non l’ho mai chiamato in maniera
diversa - rispondeva al nome di Eric Hebborn ed era il più
bravo e prolifico falsario dell’area mediterranea. Quando
pubblicò le sue memorie, qualche anno fa, in un libro
intitolato “Troppo bello per essere vero”, in cui si
raccontava come le case d’asta avessero comprato da lui
centinaia di falsi da rivendere immediatamente sul mercato, lo
scandalo fu enorme. Ma lui si divertiva a questo genere di
polemiche e fece seguire un libro sfottente che si chiamava
“Manuale del falsario”, in cui rincarava la dose.
Non eravamo veramente amici. Ma ogni tanto lo andavo a trovare,
perché le sue storie sui falsi erano assolutamente esilaranti e
combaciavano con altre storie che mi aveva raccontato, anni
prima, il più grande scopritore di falsari, Pico Cellini. Gli
avevo commissionato, per puro divertimento, due opere alla
“maniera di”, due falsi insomma: un Hockney e un Klee.
Hebborn accettò subito di dipingere il falso Hockney che non
presentava alcuna difficoltà, come testualmente mi disse, il
perfido. Quanto a Klee, era tutta un’altra cosa, perché
dipingeva ad acquarello, difficilissimo da realizzare,
contrariamente a quello che tutti pensano, e ancora più
difficile da contraffare. E alla fine non se ne fece nulla,
perché Eric morì improvvisamente cadendo dalle scale di casa,
dissero, ubriaco (ma probabilmente lo hanno ammazzato e credo di
conoscere anche le ragioni).
Elisa lavora all'acquarello in maniera molto diversa da Klee,
che con tutta la sua leggerezza ha sempre antenati teutonici,
altrimenti non ce l’avrebbe fatta a trasportare su tela o
cartone tutto quel mondo, come contenuto in un acquario o nel
liquido trasparente di una cellula e visto al microscopio. Elisa
non ha questi patemi di linea e di controllo, lascia che
l’acqua trasbordi e che vada in giro senza troppi controlli,
lasciando molto al caso. Ma è un caso di cui è andata alla
caccia o sulle tracce, come i grandi fotografi alla Cartier
Bresson: anche loro si erano affidati al caso, ma in una maniera
tale da incontrarlo, prima o poi. E nessuno ha mai avuto dubbi,
guardando le sue opere, che anche questa volta l’imprevedibile
e il non controllabile abbiano fatto il loro dovere.
-
(Stefano Malatesta)
- “L’ombra
e la luce nel linguaggio della memoria cromatica”
Collettiva
a
cura di Piero Longo
- Singolare
e bella collettiva, questa visibile alla galleria Elle
Arte fino all'8 dicembre 2004.
- Singolare
e bella, non solo per la evidente qualità delle opere
in esposizione, ma soprattutto per la varietà di
stili, tecniche e linguaggi praticati dagli artisti
che le hanno realizzate.
- Se
le collettive, infatti, hanno una finalità, essa
consiste proprio nell’offrire una panoramica quanto
più allargata possibile sulla produzione artistica
attuale. Ebbene, in tal senso, questa piccola, ma
articolata mostra si rivela inusitatamente in grado di
fornire una visuale davvero assai ampia, garantendo
agli osservatori una molteplicità di ottiche e di
punti cardinali con cui orientarsi (o forse
disorientarsi) a meraviglia nel contingente scenario
su cui si esplicano le nostre arti visive.
- Una
dote che si percepisce con inesorabile chiarezza
soprattutto nella predominante (all’interno di
questo allestimento) pittura di veduta e di paesaggio,
nei cui elastici perimetri è possibile confrontare a
perfezione l’operato di artisti – siciliani e non
– sintonizzati su lunghezze d’onda lessicali
talora davvero del tutto contrapposte.
- Ecco,
allora, i delicati ed empatici paesaggi insulari di
Pascal Catherine o le miniaturistiche vedute cittadine
di Mario Mirabella jr. o, ancora, gli aerei e luminosi
scorci di Palermo del romano Campi dialogare – fino
ad una franca e apertamente conflittuale dialettica
visiva – con le espressionistiche e acidamente
dilavate (al limite dell’informale dissoluzione)
“visioni” metropolitane di Croce Taravella o con i
vibranti – per la declinazione
“impressionistica” di luce e di colore –
paesaggi isolani di Vincenzo Nucci o, infine, con la
metafisica e surreale – per la meditativa e pausata
“nocturnitas” che la pervade – paesaggistica di
Caputo.
- Analogamente,
le caricaturali figure di Bruno Caruso, marcatamente
deformate nel sembiante come a volerne enucleare
l’intima natura psicologica, si trovano affiancate
alle ectoplasmiche sagome di rete metallica realizzate
da Gloria Argeles, le cui umbratili proiezioni –
viceversa – evidenziano l’assoluta evanescenza
dell’intera società.
- Un
continuo rovesciamento d’ogni prospettiva nel suo
opposto speculare – quello offerto da questa
collettiva – che trova ulteriori conferme anche sul
versante apparentemente più quieto della natura
morta, ove il graffitistico tratteggio da aracnide di
Bice Triolo, coi suoi sfrangiati e caleidoscopici
cangiantismi coloristici, pare contrapporsi idealmente
al nitore calligrafico degli ironici “pacchi” di
Giannici, riproposizione attualizzata – fra il pop e
il surreale – di quei “trompe l’oeil” della
pittura classica, che ancor oggi riescono a mettere in
questione il nostro superficiale modo di percepire la
realtà.
BIAGIO
PANCINO
Memorie
(dal
6 al 20 novembre 2004)
 Evocate
dalle nebbie della storia, le immagini elaborate da Biagio
Pancino ben cinquant’anni fa ci riportano a un passato nemmeno
tanto remoto, ma dal quale pare separarci la distanza siderale
frapposta dal benessere economico degli ultimi decenni. Evocate
dalle nebbie della storia, le immagini elaborate da Biagio
Pancino ben cinquant’anni fa ci riportano a un passato nemmeno
tanto remoto, ma dal quale pare separarci la distanza siderale
frapposta dal benessere economico degli ultimi decenni.
Le
raffinate chine di Pancino narrano infatti d’una Italia
contadina, prostrata da atavica miseria e soggiogata da un
immutabile destino, il cui ricordo pare ormai essersi sbiadito
nei rivoli dell’imperante cultura consumistica che tutto
omologa e cancella irrimediabilmente.
Eppure,
le scene di duro lavoro campestre, i volti dei braccianti
alterati dalla fatica quotidiana, le fisionomie segnate dal
dramma della disoccupazione, i cortei di scioperanti
costituiscono i segni tangibili d’una temperie che ha
lungamente contrassegnato il nostro paese, e che in particolare
ha connesso Veneto (regione natale dell’artista) e Sicilia in
una comune e avversa sorte di dolorosa emigrazione.
Quanti
oggi ricordano le aspre lotte inscenate dai braccianti del
sud-Italia per ottenere il ridimensionamento di feudi e
latifondi e la conseguente redistribuzione delle terre fra i
lavoratori?
Quanti
rammentano i nomi dei tanti sindacalisti – uno fra i tanti,
Placido Rizzotto – che furono uccisi dai campieri mafiosi di
baroni e possidenti per il mantenimento a oltranza dello status
quo?
Ebbene,
queste figure, schizzate con mano giovanile ma gesto già maturo
dall’allora ventenne pittore sanstinese, ancor prima che
valenti espressioni di qualità artistiche, costituiscono una
fondamentale testimonianza storica, in grado di ricondurre
finalmente alla memoria quanto rimosso per distrazione,
ignoranza o semplice superficialità.
Un
documento, innanzitutto, e per altro assai coerente con
l’impegno politico e civile ampiamente profuso da non pochi
altri artisti in quei tempi di intensa conflittualità
ideologica e sociale (si pensi ai coevi dipinti di Guttuso, di
Migneco o Giambecchina, o ancora ai disegni di Caruso).
Ciò
che però contraddistingue queste opere, rendendole in qualche
modo uniche, è il tono assolutamente antiretorico e del tutto
esente da quegli squilli o accenti di sapore propagandistico,
frequentemente riscontrabili in tanta pittura di analoga
tematica.
Sarà
per l’euritmica adozione del rigore binario del bianco e nero,
sarà per la misuratissima sintesi di tratto o per lo spoglio
assetto compositivo, ma sta di fatto che queste chine mantengono
intatta la loro freschezza visuale e soprattutto la penetranza
del “messaggio” politico di cui erano vettrici. Nessuna
eccessiva ridondanza, nessun pleonasmo estetizzante e fuori
luogo, quindi, bensì una assoluta secchezza di eloquio, capace
di restituire con poche e pertinenti pennellate l’intera
drammaticità d’una sfavorita condizione psicologica e
socio-esistenziale. Il tutto, con una intensa partecipazione
solidaristica e con un giovanile entusiasmo, frutti certamente
d’una qualche infatuazione ideologica (dovuta ai legami con
l’intellettuale militante del luogo, il poeta Romano Pascutto,
cui i giovani di San Stino guardavano attentamente), ma sempre e
comunque in un’ottica di estraneità a quegli obblighi
“realistici” di stampo socialista (tanto cari all’arte
sovietica od ai noti orientamenti togliattiani), in virtù della
quale queste opere conservano ancora un’assoluta ed incorrotta
attualità.
Ciò
che resta, dunque, dopo cinquant’anni, è l’intonso valore
di documento storico ed artistico, in grado di incrinare la
“damnatio memoriae” che avvolge quegli eventi e al contempo
di attestare la qualità d’un gesto e d’una inventiva che,
nei decenni successivi, avrebbero dato ulteriori e sempre nuove
conferme (di tipo informale e concettuale) della propria
immaginifica e irrefrenabile vitalità.

 GIACOMO
ANGILETTI GIACOMO
ANGILETTI
Fra idillio ed elegia
Colorista
morbido e avvolgente, Angiletti ha nel pastello il suo elettivo
mezzo d’espressione.
Proprio il
pastello, infatti, con la sua stesura impalpabile e aeriforme,
si rivela funzionale ad una espressività delicata e senza
eccessi, tutta tesa a enucleare e rendere al meglio la
componente più affettiva d’ogni rappresentazione.
Non è un caso,
quindi, che egli rivolga ai soggetti naturali di tipo
paesaggistico la sua attenzione prevalente, quasi a ribadire
l’impareggiabilità di questa tecnica – il pastello per
l’appunto – nella resa della più minima vibrazione
luministica o declinazione di colore. Quella luce e quei colori
tipicamente mediterranei, che Angiletti coglie con perizia e
senza enfasi cristallizzandoli in estese azzurrità di cieli ed
acque (Spiaggia), nel verdeggiare di vasti campi (Campagna
in primavera) o nell’accendersi di messi rigogliose (Grano
al vento), il tutto in un prevalere di armonici trapassi
tonalistici atti a restituire all’osservatore quella dolcezza
della natura insulare assai spesso negletta in favore d’una
visione troppo estroflessa e riverberante.
La stesura
sempre levigata e quasi serica, nella quale il nostro artista
eccelle (riproponendola peraltro, benché con minor intensità,
anche nella pittura ad olio), pur indugiando in effetti di
amalgama smaltata e in virtuosismi coloristici, e pur essendo
per lo più finalizzata ad un paesaggismo di tipo fotografico
– però stemperato in dissolvenze trasognate – che si
inscrive in una tradizione autoctona plurisecolare, sfugge
sempre, tuttavia, ad esiti di stucchevolezza o di tedioso deja
vu, in virtù della percepibile empatia che guida il pittore
calatino nel suo rapporto coi soggetti da ritrarre. E che
Angiletti ami la natura siciliana e riesca a dar corpo, coi
colori, a questo amore è cosa, infatti, che si percepisce
chiaramente osservando i suoi dipinti. Il che riscatta il suo
linguaggio figurativo dai comuni rischi dell’ovvio e risaputo,
restituendoci un artista in grado di rilanciare la pittura di
paesaggio e di veduta in termini di sicuro fascino e credibilità.
Una dote che gli va riconosciuta e che lo distingue dai tanti,
troppi figurativi insulari (e non) incapaci di uscire dai
recinti dei più facili cliché. 
Alla galleria
Elle Arte dal 16 al 30 ottobre 2004
RENATO
TOSINI
L'ombra
e lo specchio
(dal
24 maggio all'11 giugno 2004)
 Partire
con il sogno Partire
con il sogno
La
nostalgia è il sentimento ricorrente in chi avverte la
perdita di un’armonia pregressa.
Un
sentimento che Renato Tosini conosce assai bene, avendone
fatto la forza propulsiva del proprio fare artistico.
Il
suo “spleen” elegante e raffinato nasce infatti da
quell’intimo rovello che si nutre dell’acre ubbia
d’aver perso non soltanto “quel che è stato”, ma
ancor più “tutto quel che non è stato (e che avrebbe
ben potuto essere)”.
Una
sorta di elegiaco “panta rei” – per dirla con
Eraclito –, però inteso come impossibilità assoluta
“di reimmergersi in un fiume” nel quale in più di un
caso “non ci si era mai bagnati”.
Sarà
forse per questo, che nei suoi ultimi dipinti quel
metodico proceder “per levare” pare essersi ormai
spinto alle estreme conseguenze, riducendo il colore a
un’essenza diafana e leggera, liquidamene trasparente
nella sua resa rarefatta
ed
atmosferica. Una pittura quasi fantasmatica, quindi, ma
non per questo afasica; anzi ancor più penetrante, ad
onta d’un eloquio assai sommesso e tutt’altro che
gridato.
Personaggi
e situazioni sono in fondo quelli di sempre, ma è il tono
delle “storie” – Tosini ama definirsi uno
“scrittore di quadri” – ad apparire più introflesso
e melancolico.
I
soliti borghesi pingui e calvi – senza dubbio una
proiezione soggettiva dell’autore, nonchè sua
indiscussa e peculiare cifra stilistica –, elegantemente
abbigliati con grisaglia d’ordinanza e ossessivamente
seriali nella loro uniformità somatica, sembrano infatti
essersi spogliati delle armi reattive dell’attonito
stupore e della stridente regressione nel mondo
dell’infanzia, quasi avessero ceduto a un delirio
solipsistico, testimone della resa all’urto del reale.
Non
sono più i balocchi – barchette a vela, aquiloni,
trottole e tricicli –, dunque, a fare da ironico e
surreale contrappeso alle mostruosità del mondo
circostante (alla cui edificazione però si è dato un
decisivo contributo), ma una bottiglia di liquore in cui
annegarsi rievocando le atmosfere de “L’assenzio” di
Degas.
Il
bambino troppo cresciuto (o più propriamente mai
cresciuto), raffigurato abitualmente da Tosini, si è
infine dissolto in un adulto disperso nella plumbea
solitudine metropolitana o inanemente ripiegato a vergare
sulla sabbia effimere parole destinate alla cancellazione.
E
pur tuttavia, la poetica sottesa a quest’ultimi dipinti
è la stessa di quelli precedenti. Lo sbiadimento
coloristico e la riduzione degli abituali riferimenti
architettonici (quell’edilizia leviatanica e incombente
eletta ad incarnare l’orrore della contemporaneità) non
negano infatti in alcun modo l’abituale e pungente vena
d’ironia; piuttosto ne amplificano quell’amaro
retrogusto in cui risiede la grandezza narrativa di Tosini.
La
ricorrente presenza dell’elemento acquoso, a legare
simbolicamente le opere di ieri a quelle odierne, conferma
l’assenza
di cesure e delinea la naturale evoluzione del linguaggio
dell’autore. Quello del mare quale “eu-topos”, quale
ideale luogo d’ogni vera libertà, ove intraprendere il
“viaggio” che potrebbe riscattare dal giogo
esistenziale, è pertanto un comune filo conduttore
dell’intera produzione di Renato.
Ma
le barche, oggi come ieri, rimangono alla fonda o arenate
sulla spiaggia. Il “viaggio” è ancora rimandato a un
domani indefinito; poiché “Partire” si può solo
“con il sogno” e la vita – pare ricordarci Tosini
– si finisce col trascorrerla come asini alla macina,
sottomessi a un ineffabile (e in fondo comodo) non sense.
|

-
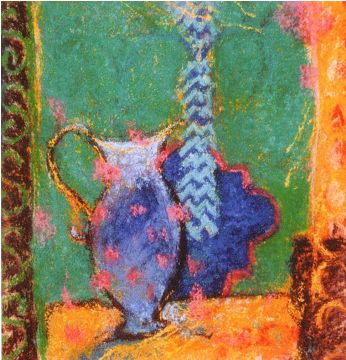 PETER
BARTLETT PETER
BARTLETT
- Da un'isola
ad un'isola
- (dal 7 al 21
maggio 2004)
- (pastelli,
oli, tempere, acquarelli)
- Luce e
colore sono quelli tipici del Mediterraneo. E lo sono anche
i soggetti, con le loro esplicite suggestioni
“orientaliste”.
- La pittura
di Peter Bartlett costituisce infatti l’ennesima conferma
di quali nuove prospettive possano aprirsi
nell’immaginario di un pittore nordico al contatto con la
natura e l’arte della Sicilia.
- Nel suo
“grand tour” personale, che lo ha portato a lasciare
l’Inghilterra per trasferirsi definitivamente in terra di
Toscana, non poteva certo mancare l’esplorazione della “Trinacria”,
quasi a segnare un simbolico (oltre che geografico) punto di
non ritorno e quindi di ripartenza nel proprio fare
artistico.
- Ripartenza
che non consiste – riteniamo – nel solo accendere le
tele di barbagli coloristici – esito cui si giunge
facilmente rimanendo a casa propria e guardando
all’operato delle avanguardie storiche –, ma riuscendo a
stabilire un rapporto di intensa empatia con l’ambiente
che si osserva (la Sicilia, nello specifico) fino a
coglierne gli umori più profondi.
- Non è un
caso, per tanto, che Bartlett si soffermi sulle vestigia –
artistiche e naturali – della dominazione araba (e dei
suoi cascami in epoca normanna), percependo il loro essere
un compiuto paradigma della sicilianità. Palme, rimandi
alle euritmie geometriche degli arabeschi, richiami
architettonici e soprattutto quel senso estetico della
vivace composizione di cromie (che caratterizza l’offerta
delle merci nei bazar arabi e nei mercati insulari)
affollano le carte del pittore inglese, restituendo al
riguardante l’essenza e le atmosfere di un contesto
vissuto con la pienezza del corpo e della mente.
- Genoardo,
Arabis, Salsibal, Estasi notturna, Andante
Palermitano, con il loro tono affabulatorio da “Mille
ed una notte”, testimoniano dunque d’una profonda e
completa comunicazione affettiva ed intellettuale con un
ambito pregno di storia e di cultura, dal quale trarre
spunti e suggestioni con cui intessere una raffinata
narrazione per immagini.
- Un percorso
conoscitivo – quello “da un’isola ad un’isola”
– che, andando ben oltre i semplici aspetti di formazione
artistica, si fa mirabile metafora d’una intensa
esperienza esistenziale.
- Il catalogo
della mostra si avvale d’un contributo critico di Tommaso
Romano.

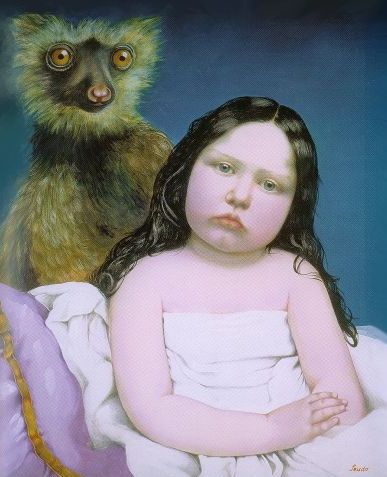 ROSSANA
FEUDO ROSSANA
FEUDO
(dal 14 marzo al
6 aprile 2004)
A cavallo dei
mesi di marzo e aprile 2004 si è svolta alla galleria Elle
Arte (via Ricasoli, 45) la mostra della pittrice romana
Rossana Feudo che è tornata ad esporre le sue opere a Palermo
dopo una assenza di circa due anni.
Nell’ambito
di una stupefacente invenzione onirica, la pittrice ha
presentato opere realizzate con una tecnica raffinata derivata
direttamente dalla maestria dei grandi artisti del
Rinascimento italiano.
La
definizione, data da Claudio Strinati in catalogo dell’arte
di Rossana Feudo, interpreta le sensazioni più immediate che
suscitano le sue tempere. “Il mondo magicamente sospeso”,
di cui scrive Strinati, è evidente nelle opere della pittrice
che si richiamano ai miti classici e a un incantamento giocato
sulla fissità dello sguardo di bambine come bambole
dell’Ottocento e di donne di una bellezza canoviana che
popolano le sue tavole.
In realtà,
c’è una mano felice dietro ogni dipinto perché ogni
dipinto, prima di essere fermato con i pennelli e con i
colori, è elaborato da un pensiero speculativo di grande
spessore. L’innato istinto e una applicazione costante hanno
portato la pittrice ai vertici di oggi.
Giuseppe
Quatriglio
-
Il bel viso androgino ruotato verso l’osservatore,
quasi a coinvolgerlo, con lo sguardo ambiguo e misterioso, in
un sottile gioco di seduzione. Come la “Fanciulla con la
perla” di Vermeer, il personaggio ritratto in
“Masquerade” da Rossana Feudo appare infatti avvolto da un
arcano insondabile che lo eterna in una dimensione atemporale.
Abbigliato secondo la moda olandese del ‘600 – seppur in
maniera più vezzosa, senza il tipico rigore protestante –,
con la gorgiera tratteggiata con fiamminga precisione, questa
figura (in cui convergono, fondendosi, il maschile e il
femminile) conferma il singolare talento dell’autrice,
tecnicamente impeccabile nell’uso della tempera su tavola
(rinnovando così un uso squisitamente rinascimentale) e
profonda conoscitrice dell’arte di altri tempi.
La Feudo – le cui opere tornano ad essere esposte, a due
anni di distanza, alla galleria Elle Arte – non è dunque,
come qualcuno potrebbe erroneamente credere (alla luce della
sua attività di restauratrice), semplicemente una pittrice
animata da una filologica pulsione “antiquariale”; perché
nei suoi dipinti la lezione dei grandi artisti del passato –
benché studiata attentamente – è solo lo spunto di
partenza per articolate e raffinate riflessioni condotte
all’insegna d’un notevole spessore psicologico.
E’ l’ambiguità, infatti, la nota dominante dei suoi
ritratti femminili. Siano essi di matrice tipicamente
rinascimentale o di palese ascendenza simbolista (con una
ostentata preferenza per i preraffaelliti), da essi promana
sempre un fascino misterico e inquietante, tipico di chi
racchiuda in sé l’angelico e il diabolico. Ecco allora la
“Minerva di Thule” – dipinta di profilo e dotata di elmo
e corazza come un condottiero verrocchiesco-leonardesco –
emergere col suo eburneo candore dall’oscurità dello
sfondo, con un sembiante incerto e sospeso fra mascolina
marzialità e muliebre languore. Oppure il “Cherubino”, la
cui ascetica dolcezza appare, qui e là, maliziosamente venata
d’un languido abbandono, degno più d’un “erotino”
classico (o manieristico) che d’una sacra immagine.
Ma è in dipinti quali “Apparizione” e, soprattutto,
“Ragazza e rose”, che la pittrice romana raggiunge
l’acme della sua raffinata tecnica e della non comune
capacità di inquietare. Effigiate come divinità silvane –
affioranti da un fitto e scuro fogliame – o come svenevoli
fanciulle ottocentesche – in un profluvio di rose policrome
–, le bellezze della Feudo suscitano immancabilmente una
sorta di amor fati, incarnando alla perfezione il mito
simbolista della donna angelicata che, sotto mentite spoglie,
cela una mantide (o un vampiro) in grado di irretire e poi
distruggere. Vengono alla mente le parole di Oscar Wilde:
“Le donne perverse ci tormentano. Le donne buone ci
annoiano. Ecco la differenza fra di esse”.
Una differenza che, però, Rossana Feudo è riuscita abilmente
a mascherare.
-
Salvo Ferlito
- MARIO
BARONE
- "
NUVOLE "
-
- Dal
20 febbraio 2004.
- Nuvole
in fuga verso un altrove non meglio definito.
- Addensate
in grigi cumuli o disperse e rarefatte sull’intonsa superficie
cartacea dei supporti, le nuvole dipinte da Mario Barone paiono
infatti procedere per autonome cinetiche inerziali di matrice
intrapsichica, di fatto estranee all’impetuoso agire di
qualsivoglia forza “naturalmente eolica”.
- Quello
naturalistico è dunque un semplice pretesto; un presupposto
narrativo, dal quale il nostro pittore ama idealmente muovere
nei suoi percorsi immaginifici di progressivo straniamento
dall’ambito “terreno”, evidentemente vissuto come troppo
angusto e costrittivo. Gli “aerei” paesaggi che ne sono
scaturiti hanno pertanto una preminente valenza
allegorico-simbolica, davvero in grado di travalicare il mero
dato percettivo e fotografico, in funzione dell’esclusiva
proiezione dei vissuti affettivo-emozionali.
- Si
spiega in questi termini l’adozione assai frequente di
orizzonti ribassati – incombenti su più o meno cupe azzurrità
marine o su grigi profili rocciosi appena ravvivati da cespugli
–, grazie ai quali lo stacco ascensionale delle nubi assume
una evidenza ottica (e soprattutto metaforica) ancora più
marcata. In tal modo, Barone pare voler guidare il nostro
sguardo all’interno d’un paesaggio (perché, in fondo,
d’un unico paesaggio si può parlare, sebbene declinato in
molteplici varianti) che è innanzitutto “panorama
interiore” (della psiche o dello spirito, a seconda delle
ottiche), però riportato nei modi e nelle forme
dell’apparente ossequio alla natura.
- In
tal senso, la scelta di un linguaggio aeriforme e rarefatto,
supportato da una tecnica adeguata (ovvero da un acquarello
tonalmente diluito su ampi spazi, coi pigmenti stesi a macchie
in maniera anche discontinua), si rivela pertinente e funzionale
al coinvolgimento (sensoriale e cognitivo) degli osservatori,
magneticamente richiamati all’interno di un contesto più
intimistico e soggettivo, che strettamente materiale. Un lessico
non estemporaneo ed immediato, ma maturato per lenta e
progressiva decantazione del colore, altrove – per
l’esattezza in opere pregresse – dispiegato con inusitata
compattezza e intensità.
- Anche
in quelle gouaches, in vero, la fedeltà vedutistica al
paesaggio non era che un puro espediente per dissertazioni
eminentemente simboliche e tendenzialmente astratte, dovute al
comporsi quasi geometrico delle spesse campiture o a
sfrangiamenti timbrici simil-divisionisti. Tuttavia, procedendo
qualitativamente “per levare” da questi precedenti, quindi
sottraendo densità ed estensione alle cromie ed alleggerendo il
tutto fino a renderlo impalpabile, Barone ha dimostrato di
potere pervenire a una pittura aerea e trasparente, al contempo
essenziale e rigorosa, dotata di puro incanto ma senza cedimenti
liquorosi, e in qualche modo “universale” nel suo essere
assolutamente refrattaria a qualsivoglia tentazione di
esasperata mediterraneità.
- E
questo, grazie ad un percorso al quale non sono indifferenti
profonde riflessioni sulla grande paesaggistica anglosassone
dell’ottocento – Turner in special modo – e forse anche
sui precursori olandesi del seicento – van Ruysdael per
esempio –, dai quali il nostro autore ha saputo mutuare
quell’afflato – già precontemporaneo – alla
rappresentazione simbolica dell’interiorità, idealmente
proiettata su più o meno fosche turbolenze cirro-nembiche. Iter
– quest’ultimo intrapreso da Barone – di certo non
concluso e al quale, nonostante le legittime aspirazioni alla
ricerca di sempre nuovi moduli espressivi, è auspicabile che
egli dia ancor più impulso e continuità. Il parallelo uso
degli acrilici su tavola, infatti, pur avendo gradevoli esiti
cromatici e pur perseguendo analoghe finalità allegoriche (ben
evidenti soprattutto nei notturni), ha però minor valenza
immaginifica, poiché più prossimo a tanto paesaggismo
“mediterraneistico” in cui – purtroppo – non è
infrequente imbattersi.
- E’
dunque nella spoglia e leggiadra sobrietà di queste nuove
carte, che si dispiega appieno la “poetica” visione del
nostro Mario; è proprio in quei cieli annuvolati, nei quali ama
rifugiarsi il suo io irrequieto e in continuo movimento, che la
pittura di Barone va assumendo la sua cifra più compiuta e
definita, rivelando quelle fini doti liriche in grado di
rappresentare congruamente ogni minimo moto che agisce nel
profondo.

RITRATTO DI
CASIMIRO PICCOLO
Acquerelli e
fotografie inediti
fino al
16/2/2004
- Della
famiglia Piccolo di Calanovella il più noto è senza dubbio
Lucio. Poeta, uomo di cultura di rilievo nazionale ed
internazionale, cugino di Tommasi di Lampedusa, cui lo
legava anche il comune interesse per le lettere, Lucio
Piccolo ha incarnato alla perfezione il
modello dell’aristocratico eccentrico ed
intellettuale, estraneo alle meschinità del mondo e
disinteressatamente dedito alle attività artistiche.
- Assai
meno conosciuto, ma non per questo meno valido
od interessante, è l’operato del fratello
Casimiro, il quale è stato un buon fotografo ed
acquerellista, e soprattutto uno straordinario disegnatore.
- Se
nella fotografia – pratica per altro molto diffusa nelle
classi egemoni dell’epoca – gli interessi paiono
orientati verso “classiche” tematiche
naturalistico-botaniche (fiori, agavi) ed
etno-antropologiche (contadini, zampognari, carusi-operai),
quest’ultime trattate con un piglio scarsamente
sociologico – tipico, purtroppo, dei nostri aristocratici
– e tendenzialmente bozzettistico-veristico, nella
pittura, invece, l’immaginazione di Casimiro Piccolo pare
librarsi con originale inventiva fabulistica, sconfinando
nei territori del magico e del fantastico.
- Infatti,
accanto a una produzione paesaggistica decisamente più
scontata e a qualche piccolo ritratto coerente con i
suddetti gusti fotografici (da cui si discosta solamente,
per la qualità intimistica, un’immagine di Teresa Tasca
Filangieri, colta di spalle intenta a lavorare), è la serie
di piccoli e deliziosi disegni colorati ad acquarello,
raffiguranti elfi, maghi e vari personaggi, a costituire –
senz’ombra di dubbio – il meglio della pittura del
nostro nobiluomo.
- Anticipando
di molti decenni le atmosfere “potteriane”, oggi così
in voga, l’artista siciliano ha saputo infatti dare forma
delicata ed elegante – senza quindi scadere in una
visionarietà macabra od orrorifica – ad un universo
misterioso ed esoterico, del quale, sensitivamente, egli
avvertiva il murmure sommesso ma vivace.
- D’estrema
raffinatezza grafica, riccamente colorati con morbidi
effetti di trascoloramento atmosferico, tratteggiati con
gusto gradevolmente caricaturale, questi piccoli personaggi
rappresentano per tanto la migliore testimonianza d’una
poetica incantata e visionaria, al contempo canto del cigno
e simbolico ultimo rifugio d’una sensibilità
aristocratica probabilmente già consapevole
dell’inarrestabile declino del proprio mondo. In tal
senso, essi costituiscono l’imperdibile documento visuale
d’una era ormai conclusa – quella del predominio
baronale – che, pur fra i tanti guasti arrecati alla
società, ha fortunatamente saputo anche lasciare valide
vestigia, degne di profonda ammirazione.

|