|
 |
|

| |
| |
-
AVANGUARDIE
RUSSE
-
(fino al 20 marzo
2012)
-
-
 <<…Le
avanguardie sono un fenomeno tipico dei paesi
culturalmente arretrati; il loro sforzo, benché
intenzionalmente rivoluzionario, si riduce generalmente
a estremismo polemico…>>. <<…Le
avanguardie sono un fenomeno tipico dei paesi
culturalmente arretrati; il loro sforzo, benché
intenzionalmente rivoluzionario, si riduce generalmente
a estremismo polemico…>>.
-
Valutazione quanto mai
congrua e pertinente, questa formulata da Giulio Carlo
Argan, in quanto in grado di inquadrare a perfezione il
contesto storico (più precisamente economico, sociale e
culturale) al cui interno sono maturate e si sono
inscritte tutte le pulsioni catartiche e palingenetiche
dei tanti che, da almeno centocinquant’anni, hanno
mirato a rivoluzionare non solo le dinamiche (o meglio
ancora le inerzie) delle arti visuali, ma – più in
generale – qualsiasi forma di ordine precostituito in
atto e vigente nell’intero orbe terraqueo.
-
Va detto – a onor del vero
– che l’interessante analisi di Argan è stata elaborata
in riferimento al solo Futurismo italiano, rivelando un
così radicato pregiudizio ideologico (da comunista
militante che valuti un fenomeno ascrivibile al
nazionalismo e al fascismo), tale da limitarne quell’assolutezza
paradigmatica che ne consentirebbe – invece – una più
lata (e logica) estensibilità ad altri fenomeni coevi.
-
Non è un caso, per tanto,
che proprio in relazione all’avanguardia russa (le cui
varie correnti molto devono al suddetto Futurismo ed al
Cubismo, intrecciandosi però assai strettamente con gli
eventi insurrezionali bolscevichi) egli abbia parlato di
<<…sola che si inserisca in un concreto processo
rivoluzionario e ponga come politica la funzione sociale
dell’arte…>>, a inequivocabile dimostrazione di come la
lettura dei fenomeni culturali – in special modo
artistici – del cosiddetto “secolo breve” abbia
risentito – e risenta ancor oggi – di rigorosi
schematismi il cui tasso di interferenza risulta fin
troppo rilevante ed oneroso.

-
E’ da questi fondamentali
presupposti, dunque, che bisogna muovere nel prendere
visione della mostra Avanguardie Russe
(allestita al Reale Albergo dei Poveri di Palermo fino
al 20 marzo), e cioè cercando di sfruttare la stimolante
occasione per un tentativo di emancipazione – nei limiti
del possibile – da “griglie” interpretative di matrice
storico-artistica fin troppo “cogenti” ed “orientanti”,
ed approfittando di questa ampia panoramica per operare
delle valutazioni di carattere artistico ed estetico che
siano – nei limiti del rispetto della
contestualizzazione storica – almeno parzialmente immuni
da partigianerie ideologiche.
-
E’ fuor di dubbio – e la
mostra ne dà ampiamente atto – che senza l’irruzione del
verbo cezanniano, di quello matissiano e cubo-futurista
nello scenario della Russia dello Zar – e questo ci
riporta ancora alla riflessione sul provincialismo, e
quindi sulle condizioni “presunte” o “effettive” di
retroguardia e arretratezza, quale premessa ineludibile
di qualsivoglia slancio avanguardista –, con molta
probabilità, assai difficilmente si sarebbe assistito al
fiorire d’un movimentismo “russofono” (dal Raggismo al
Suprematismo e al Costruttivismo) nei termini e nei modi
in cui esso venne a svilupparsi, ovvero privilegiando –
nelle sue espressioni più radicali – l’adesione quasi
incondizionata ad una koinè linguistica sopranazionale e
relegando gli aspetti della tradizione in ambiti
estremamente ridotti e contenuti. In tal senso, il ruolo
giocato dalle opere d’arte contemporanea importate nel
territorio russo da collezionisti – indubbiamente
illuminati – come Scukin e Morozov (che facevano, per
così dire, “compere” nella “ville lumière”) e anche
l’istrionica peregrinazione in quelle terre
dell’immancabile Marinetti (innanzitutto propagandista e
promotore, attraverso il Futurismo, di se stesso) si
rivelarono senza dubbio determinanti ai fini
dell’innesto, in un terreno già fertile e magmatico, di
difformi paradigmi rispetto ad una consolidata
tradizione figurativa (per altro già ricca, al volger
dello ‘800, di interessanti analisi sociali e prese di
posizione di carattere politico) e ad orientamenti
tematici marcatamente autoctoni.
-
Proprio le opere esposte
all’Albergo dei Poveri consentono di verificare
fondatamente – se si adotta quel giusto distacco
“intellettuale” dalle romanticherie e dagli armamentari
ideologici cui si è già alluso all’incipit di questo
discorso – come il prevalere di pur legittime impellenze
ed esigenze di inclusione in innovativi movimenti di
pensiero estetico ed artistico provenienti dall’esterno
abbia tuttavia determinato, laddove hanno prevalso
l’eccessivo zelo dei neofiti e la scrupolosa ortodossia
degli iniziati, degli esiti di tipo rigidamente e
marcatamente “castratori”, rispetto a quelle componenti
di inventiva e spontaneità che abitualmente si pascono
di spunti e suggestioni mutuati dall’inevitabile
retroterra di matrice etno-antropologica.
-
 Fatti
salvi, infatti, alcuni indiscutibili raggiungimenti
della cultura visuale russa di quelle epoche – il
Suprematismo di Malevic, con la sua palese capacità di
giungere all’essenza del linguaggio
astrattista-geometrico e di mettere a nudo i limiti
estremi oltre i quali si dissolve il valore semantico
delle immagini, e ancora l’apporto di Kandinskij alla
nascita dell’Espressionismo astratto, in virtù d’una
impareggiabile attitudine a bilanciare la dissoluzione
della forma, la liberazione del gesto e l’intensità
emozionale ed affettiva del colore, e infine la
visionarietà utopistica del Costruttivismo di Tatlin, in
cui si concretizza formalmente l’aspirazione anche
delirante ad azzerare il tutto per fare ripartire la
“Storia” attraverso una complessiva ricostruzione
estetica e politica della società –, molta della
produzione visiva di allora – improntata ad una esibita
volontà di infrazione d’ogni norma convenuta – può oggi
apparire piuttosto ingenua (come è tipico d’altronde
d’ogni slancio idealistico e pulsione passionale) e in
qualche caso anche alquanto imbarazzante. Certe opere
della Rozanova (le varie Carte da gioco),
altre della Goncarova (Orchidee,
Decorazione elettrica), l’ossequio al
cubo-futurismo variamente declinato dalla Popova (Natura
morta), dalla Udaltsova (La chitarra. La
fuga), daVasil’evic Le-Dantu (Signora in
un caffè), da Menkov (Sinfonia. Violino),
dalla Pestel (Composizione), e ancora
certe soluzioni a metà fra astrazione geometrica e
dinamismo futurista sempre della Popova (Costruzione
di forza nello spazio) si configurano, infatti,
come manifestazioni visuali ove l’adesione entusiastica
ad indicazioni di provenienza internazionale ha finito
con l’indurre effetti “imitativi” assai poco
personalizzanti e sostanzialmente riconducibili ad una
koinè linguistica dai connotati altamente ripetitivi.
Altro discorso, invece, va obbligatoriamente formulato
per tutte quelle opere nelle quali il carattere profondo
e inconfondibile della cultura russa – lo spiritualismo
misticheggiante, l’afflato favolistico, il radicamento
nel mondo contadino – appare ben amalgamato con i
suggerimenti provenienti dal milieu occidentale, in un
“mélange” contraddistinto dall’effettiva capacità di
sfruttare le spinte innovative per rivitalizzare una
tradizione altrimenti destinata a sclerotizzarsi in
moduli estremamente conformistici e convenzionali (così
come sarebbe accaduto di lì a poco con l’imporsi del
“realismo socialista” di dettame staliniano). Ecco,
allora, le tante declinazioni in salsa russa del verbo
cezanniano ammantarsi di atmosfere sospese e
melancoliche, conferendo alla ritrattistica un carattere
intimistico estremamente peculiare (Nudo con
tappeto asiatico sullo sfondo di Kuprin,
Ritratto femminile di Falk, Ritratto di
donna con chitarra di Lentulov o Ritratto
di poeta di Maskov), a dimostrazione di come lo
squillo coloristico e le stesure piatte e assai
sintetiche possano sposarsi a perfezione con una dote
d’empatia ed un’attitudine allo scavo psicologico di
derivazione del tutto territoriale (si pensi alla
letteratura coeva e precedente, Dostoèvskij sopra
tutti), senza che ciò comporti tuttavia arrendevolezze o
cedimenti a semplificazioni assai banali e fin troppo
modaiole. Analoghe considerazioni per le varie nature
morte – da quelle della Rozanova e di Kuprin a quelle di
Koncaloskij, di Rozdestvenskij e di Menskov – nelle
quali le varie innovazioni matissiane e cezanniane si
fondono compiutamente con una vivacità fanciullesca che
è tipica dello esprit locale. Fatti
salvi, infatti, alcuni indiscutibili raggiungimenti
della cultura visuale russa di quelle epoche – il
Suprematismo di Malevic, con la sua palese capacità di
giungere all’essenza del linguaggio
astrattista-geometrico e di mettere a nudo i limiti
estremi oltre i quali si dissolve il valore semantico
delle immagini, e ancora l’apporto di Kandinskij alla
nascita dell’Espressionismo astratto, in virtù d’una
impareggiabile attitudine a bilanciare la dissoluzione
della forma, la liberazione del gesto e l’intensità
emozionale ed affettiva del colore, e infine la
visionarietà utopistica del Costruttivismo di Tatlin, in
cui si concretizza formalmente l’aspirazione anche
delirante ad azzerare il tutto per fare ripartire la
“Storia” attraverso una complessiva ricostruzione
estetica e politica della società –, molta della
produzione visiva di allora – improntata ad una esibita
volontà di infrazione d’ogni norma convenuta – può oggi
apparire piuttosto ingenua (come è tipico d’altronde
d’ogni slancio idealistico e pulsione passionale) e in
qualche caso anche alquanto imbarazzante. Certe opere
della Rozanova (le varie Carte da gioco),
altre della Goncarova (Orchidee,
Decorazione elettrica), l’ossequio al
cubo-futurismo variamente declinato dalla Popova (Natura
morta), dalla Udaltsova (La chitarra. La
fuga), daVasil’evic Le-Dantu (Signora in
un caffè), da Menkov (Sinfonia. Violino),
dalla Pestel (Composizione), e ancora
certe soluzioni a metà fra astrazione geometrica e
dinamismo futurista sempre della Popova (Costruzione
di forza nello spazio) si configurano, infatti,
come manifestazioni visuali ove l’adesione entusiastica
ad indicazioni di provenienza internazionale ha finito
con l’indurre effetti “imitativi” assai poco
personalizzanti e sostanzialmente riconducibili ad una
koinè linguistica dai connotati altamente ripetitivi.
Altro discorso, invece, va obbligatoriamente formulato
per tutte quelle opere nelle quali il carattere profondo
e inconfondibile della cultura russa – lo spiritualismo
misticheggiante, l’afflato favolistico, il radicamento
nel mondo contadino – appare ben amalgamato con i
suggerimenti provenienti dal milieu occidentale, in un
“mélange” contraddistinto dall’effettiva capacità di
sfruttare le spinte innovative per rivitalizzare una
tradizione altrimenti destinata a sclerotizzarsi in
moduli estremamente conformistici e convenzionali (così
come sarebbe accaduto di lì a poco con l’imporsi del
“realismo socialista” di dettame staliniano). Ecco,
allora, le tante declinazioni in salsa russa del verbo
cezanniano ammantarsi di atmosfere sospese e
melancoliche, conferendo alla ritrattistica un carattere
intimistico estremamente peculiare (Nudo con
tappeto asiatico sullo sfondo di Kuprin,
Ritratto femminile di Falk, Ritratto di
donna con chitarra di Lentulov o Ritratto
di poeta di Maskov), a dimostrazione di come lo
squillo coloristico e le stesure piatte e assai
sintetiche possano sposarsi a perfezione con una dote
d’empatia ed un’attitudine allo scavo psicologico di
derivazione del tutto territoriale (si pensi alla
letteratura coeva e precedente, Dostoèvskij sopra
tutti), senza che ciò comporti tuttavia arrendevolezze o
cedimenti a semplificazioni assai banali e fin troppo
modaiole. Analoghe considerazioni per le varie nature
morte – da quelle della Rozanova e di Kuprin a quelle di
Koncaloskij, di Rozdestvenskij e di Menskov – nelle
quali le varie innovazioni matissiane e cezanniane si
fondono compiutamente con una vivacità fanciullesca che
è tipica dello esprit locale.
-
Ma è soprattutto nella
pittura di Chagall – qui in vero rappresentata nelle sue
forme più prodromiche, non ancora pervenute al proprio
acme visionario –, in cui il retaggio del mondo ebraico
si esprime in termini di palese radicamento
nell’immaginario della Russia più profonda (come in
Bagno di bimbo o Negozio a Vitebsk),
che gli aspetti della narrazione fiabesca raggiungono
dei vertici assolutamente incommensurabili, conferendo
all’arte russa del primo Novecento un carattere del
tutto autonomo e qualitativamente peculiare. Si spiegano
così le atmosfere alla Sherazade che
permeano il paesaggismo e il vedutismo di Lentulov (Paesaggio.
Chiese.Nuova Gerusalemme e Antico Castello
in Crimea. Alupka) o quelli di Kuprin (Paesaggio
con chiesa) e per certi versi anche quelli
spettacolari, vorticosi e caleidoscopici del Kandinskij
ancora in itinere verso l’astrattismo più libero e
informale (Mosca. Piazza rossa). Simili
riflessioni vanno condotte anche per le rivisitazioni
dei temi contadini e per i ripensamenti della pittura
sociale di fine ‘800 variamente effettuati in una
aggiornata veste d’avanguardia. E’ il caso delle
ipercromiche dissertazioni della Goncarova (Donne
con rastrello) e di Larionov (Rissa in un
locale), nelle quali la sintesi figurativa e
l’accensione coloristica si fanno funzionali
vessillifere d’una profonda pregnanza narrativa; ma è
massimamente nel paradigmatico ed esemplare apporto –
ancora una volta – di Malevic (Il falciatore)
che quanto fin qui detto giunge ad una evidenza del
tutto inoppugnabile: ovvero ad una summa compiuta di
quella attitudine, tipica dei grandi artisti, ad
innestare nei terreni del vissuto individuale e del
personale immaginario le migliori suggestioni e i più
vitali spunti provenienti dall’esterno – estrema sintesi
formale, accensione coloristica, stesura
caratteristicamente piatta –, dando infine corpo ad
esiti linguistici totalmente inattesi, che però, nella
loro radicale innovazione, giammai rinnegano né tanto
meno cancellano il peso e il valore d’una grande
tradizione.
Salvo Ferlito
|
| |
ANNI PRECEDENTI
|
 |
|
|
|
-
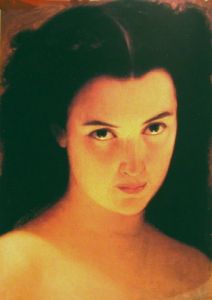 LA
RICERCA DELL’IDENTITA’ LA
RICERCA DELL’IDENTITA’
- Fornire
una definizione valida e compiuta di cosa sia l’identità
è compito assai arduo. Frutto d’un intreccio
inestricabile di fattori psicologici, sociali e
antropologici, essa appare infatti irriducibile a qualsiasi
modello ideale o formula precisa.
- Senza
andare a scomodare la filosofia, la religione o la
psicoanalisi, e volendo permanere nel novero delle arti
visive (che pure dalle suddette sono state ampiamente
influenzate), si può ben affermare che proprio alla
pittura, alla scultura ed alle più recenti fotografia,
cinematografia e videoarte si devono le più riuscite
rappresentazioni dell’identità elaborate nel corso dei
millenni.
- Lo
dimostra, con inoppugnabile chiarezza, la monumentale mostra
curata da Vittorio Sgarbi – “La ricerca dell’identità”
da Antonello a de Chirico, visibile all’Albergo delle
Povere fino al 17 febbraio –, non per nulla incentrata
sulla ritrattistica, chiamata qui a narrare l’evolversi,
negli ultimi cinquecent’anni, del modo di raffigurare
l’immagine dell’io, colto nei suoi aspetti più
intimistici e sociali.
- Non
è un caso, quindi, che il percorso espositivo parta proprio
col “Ritratto di ignoto marinaio” di Antonello da
Messina; non è un caso, perché questo dipinto – in cui
si sposano il crudo gusto realistico per il particolare di
ascendenza fiamminga con le acquisizioni prospettiche e la
maggiore morbidezza della pittura italiana – è un vero
manifesto delle possibilità di scavo psicologico insite
nella grande ritrattistica. Infatti, quest’uomo
sconosciuto, che guarda in tralice verso gli osservatori con
occhi furbi e penetranti, dal sorriso accennato e sfuggente,
è forse la migliore (e più riuscita) descrizione
dell’identità insulare, ovvero di quella “metis” –
un po’ luogo comune e un po’ carattere reale – che fa
dei siciliani un popolo al contempo assai amato e
disprezzato.
- Le
certezze e le fierezze di quest’uomo antonelliano –
esempio della centralità assegnata dal Rinascimento
all’uomo naturale e sociale – paiono però
progressivamente cedere e iniziare a sgretolarsi già a
partire dal primo ‘500. Da quel momento in poi – come
rivelano il ritratto dell’Aretino dipinto da Tiziano, il
giovane languoroso di mano del Giorgione e gli introversi
personaggi di Lorenzo Lotto –, una profonda vena di
maliconia sembra
via via insinuarsi nei volti e nelle pose, aprendo a quella
crisi dell’identità (individuale e collettiva) che
culminerà con le nevrosi del ‘900 e con la franca
alienazione della contemporaneità.
- Nobili,
prelati, santi, pitocchi, borghesi, contadini e studiosi,
donne estatiche (come l’orgasmica “Santa Teresa”
del Morazzone, corrispettivo pittorico di quella berniniana),
assorte (la “Santina Negri” di Pellizza da
Volpedo), deliranti (l’intensissima “Ofelia”
del Rapisardi) o vampiresche (quelle dipinte da Lorenzo
Viani con tratto quasi espressionistico), teschi più o meno
decomposti (del Ligozzi), mostri e freaks d’ogni tipo
(dalla “Cieca” del Carracci al caricaturale busto
in cera di Vittoria di Savoia realizzato da Francesco Orso),
fantasmi e figure evanescenti si susseguono in una ideale
galleria di tipi e di profili socio-psicologici, in grado di
declinare la tematica di fondo con uno spettro assai ampio e
variegato, ma di certo non completo.

- Oltre
ad Antonello, infatti, non compare alcun altro pittore del
‘400, e questa, ai fini d’una visuale più allargata,
costituisce una pecca non da poco. Inoltre, non v’è
traccia dell’impronta di Leonardo, i cui studi
fisiognomici hanno condizionato in modo irrevocabile
l’espressione degli “affetti” da parte dei pittori
successivi. Manca del tutto la ritrattistica ufficiale
manierista di tipo bronzinesco, e quindi quella smaltata
modalità di rappresentazione del rango alla quale fu
sottratto ogni slancio emozionale. Latitante anche l’Arcimboldo
(sarebbe bastato qualche suo epigono o copista), che fu
artefice di quella spiazzante coesistenza di unico e
molteplice in grado di frammentare formalmente una stessa
identità. Altrettanto lacunosa, la trattazione del tema
dell’assenza e dell’annullamento, la quale avrebbe
meritato una qualche anticipazione seicentesca (per esempio,
con una natura morta con strumenti musicali del Baschenis,
emblematica della “fine del concerto” e quindi del
termine dell’esistenza) e non solo il confinamento (seppur
di grande valore artistico, con i vuoti ambienti di Sironi,
Ar e Ferroni) nell’ambito del secolo trascorso. Infine, la
stessa contemporaneità appare scandagliata parzialmente,
senza alcuna considerazione per tecniche e linguaggi più
attuali (fotografia, videoarte, per fare qualche esempio).
- Pur
rifuggendo da presunti criteri di “scientificità” –
inesistenti in campo umanistico, checchè ne pensi qualche
“convinto” addetto ai lavori di accademica estrazione
–, rimane il fatto incontestabile che una mostra così
importante, soprattutto se organizzata con soldi pubblici,
non possa essere lasciata ai semplici e soli “gusti” del
curatore (motivazione che puzza tanto di excusatio non
petita), imponendo delle scelte un po’ più rigorose.
- L’inoppugnabile
bellezza ed importanza di molte delle opere in esposizione
(selezionate, per altro, con un occhio attento agli artisti
siciliani) non basta del tutto a giustificare un evento che
pare improntato a prevalenti dinamiche e finalità di tipo
mediatico: dalla notorietà televisiva del curatore alla
conseguente visibilità e risonanza della mostra stessa (e
di chi la ha voluta).
- Come
già detto in precedenti occasioni, in riferimento
all’operato di altre amministrazioni (guidate sia da
politici di destra che di sinistra), la nostra città e la
regione intera necessitano di interventi artistico-culturali
non effimeri ma strutturali.

- Impiegare
il denaro della collettività per dare un assetto definitivo
ai musei isolani (e soprattutto palermitani), recuperando
quanto nascosto nei depositi (con cui si potrebbero
allestire non poche mostre di qualità), e trasformare i
centri storici in stabili spazi espositivi per opere di
artisti contemporanei, ci sembrano – francamente – più
impellenti priorità.

|
 |
Invia questa
pagina ad un amico |
|
|